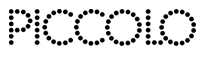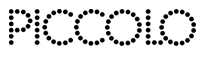Note di regia per Il campiello , pubblicate anche nel programma di sala per Il campiello, stagione 1992/93
Note di regia del Campiello di Carlo Goldoni edizione 1974-75
Perché questo “campiello”
21 gennaio 1975
Ma perché questo Campiello? È ancora la domanda di sempre che mi perseguita quando si avvera una “scelta”. Come se ogni scelta fosse soltanto razionale o soltanto “poetica”, di necessità interiore. Certo per questo Campiello esiste ad esempio una necessità abbastanza chiara all’origine, e non è una circostanza di poesia.
So che è giusto, utile, necessario che questo spettacolo sia uno spettacolo di autore italiano, proprio guardando l’arco dei tre anni: c’è Cecov, c’è Brecht, c’è Shakespeare…
È giusto, utile, necessario, (come necessario!) che si tratti di uno spettacolo “semplice” (!) cioè, almeno, con un numero limitato di attori e con pochi cambiamenti di scena: la situazione finanziaria del momento è terribile e le prospettive per il futuro estremamente incerte. È una specie di miracolo della volontà e della capacità della fantasia che il Piccolo continui a fare quello che fa, che abbia prodotto gli spettacoli che ha prodotto in questi anni e che io sia qui ad incominciare un’altre cosa “straordinaria”, fuori dalla regola, dall’immobilismo, dalla stanchezza interiore, dalla sfiducia che tutti ci pervade. È proprio per la prospettiva futura, ecco, che si affaccia un’altra ragione utile e giusta e previdente: uno spettacolo che si possa portare nel mondo. Ecco alcuni motivi che hanno spinto al pensiero Goldoni. E poi, tanti anni che non affronto più Goldoni: dalle Baruffe chiozzotte14.
Il mio discorso su Goldoni, che credo abbia portato qualcosa non al teatro italiano ma alla cultura italiana, si è arrestato molti anni fa alle Baruffe, come punta estrema di un itinerario. Altri hanno allestito tre commedie che io tante volte avevo annunciato, previsto, descritto: La casa nova, I rusteghi, Una delle ultime sere di carnovale. I rusteghi doveva seguire Le baruffe o precederle, ad esempio. In questo senso il chinarsi sul Campiello può certo essere una specie di passo indietro sul tema: Goldoni popolare. Si dice, infatti, che Il campiello può essere una prova generale delle Baruffe. Persino quel Cavaliere può rassomigliare al Cogitore, ma ancora non sviluppato, non ancora intuito poeticamente.
Questo e altro.
25 gennaio
Questa grande commedia plebea! Questo piccolo grande poema plebeo! C’è, nel terzo e nel quinto atto, una densità cifrata del linguaggio veneto, tenuto stretto, gergale, non divulgativo, veramente plebeo nella sua realtà di forza e che il verso solo esalta e fa squillare più alto, e che dovette certo fare impazzire Carlo Gozzi. Non a caso egli parla con disprezzo della Catte “che ha la gatta innamorata”, mentre Goldoni la canta.
Gozzi – ed è, mi pare, la cosa più semplice per un inizio di critica goldoniana plausibile – aveva capito tutto di Goldoni, sul suo versante reazionario-aristocratico. E bisognerebbe partire da lì: dall’accusa al Goldoni di essere cantore delle plebi, del volgare, dello “sporchezzo”; di essere Goldoni privo di gusto, che copia il “vero” plebeo, e nel cui teatro il novanta per cento dei nobili fa brutta figura o peggio; partire dall’accusa a Goldoni di pericolosità sociale, distruttiva nei rapporti della Repubblica e dei suoi costumi; dall’accusa di essere uomo che lavora per guadagnare. Goldoni fa arte, fa teatro per vivere, per mestiere, come un “vile artigiano”, falegname o altro! Tali, tutto sommato, le accuse più vere e più pericolose (dal punto di vista veramente politico, con tutti i suoi addentellati di poteri pubblici e di pericoli pubblici); e colpiscono esattamente da destra nel segno. Faceva bene Goldoni ad averne paura. Fa meraviglia che tanto si sia e si stia ancora almanaccando per definire il profilo plausibile di Goldoni senza tenere conto della sua realtà storica. Il campiello, non meno delle Baruffe poi, delle Massere e delle Donne gelose, ma con più forza, più compattezza di tutte queste, Baruffe comprese, è commedia popolare in senso profondo, non solo per il colore popolare o per i suoi protagonisti popolari: lo è senza risparmio, lo è decisamente, audacemente, violentemente…
3 febbraio
…Intorno a tutto, il clan grande e diverso dei popolani: madri e figlie. È un clan terribilmente unito e severo nel suo rituale, e qui la grande analisi tentata dal Goldoni quasi lungo tutta la sua vita aggiunge toni, note e chiarezze inconsuete. Proprio nella sua parsimonia, il mondo chiuso del campiello appare come un qualcosa di ancora compatto, con il quale si deve fare i conti. Altro che le belle baruffe degli allegri pescatori chioggiotti con il berretto folcloristico, che tanto fanno ridere con le loro liti e grida! Altro che il popolo semisottoproletario, con accenni piccolo-borghesi del campiello, che ugualmente fanno ridere con le loro inutili gelosie e la loro vita carnevalesca e folcloristica! Nel campiello il colore non c’è o quasi; neanche le barche, neanche l’arrivo della tartana, niente: in questo senso Il campiello è ancora più parco di suoni e di colore delle Baruffe. Il campiello nella sua levità, severo, senza concessioni…
17 febbraio
Il campiello, oltre che storia dei rapporti tra gli abitanti del campiello, è la storia di un difficile rapporto tra un gruppo sociale ed etnico e un altro. Da una parte il campiello-Venezia-popolo, dall’altra parte gli stranieri: napoletani, nobili, o seminobili, borghesi. Soltanto il Joly15 ha individuato una parte di questo stato dialettico, ma probabilmente per ragioni di lingua non poteva percepire più a fondo il problema più vasto. In questo rapporto, alla fine, vincono i popolani: quel povero campiello è il loro mondo e resta loro. La casa vuota di Fabrizio e Gasparina sarà occupata da una nuova futura coppia – Agnese e Zorzetto – e l’ordine costituito sarà nuovamente pacificato. Nella locanda, il luogo estraneo, potranno arrivare gli altri: ma per poco, in modo precario, forse per carnevale oggi, e d’estate per il turismo. Ma il clan è salvo e resta a guardia del campiello. Fino quando? Ovviamente ciò che il clan respinge è il corpo estraneo che può turbare l’equilibrio, mettere in forse la sopravvivenza del gruppo, o per lo meno crearvi difficoltà. Ma qui nel campiello, a parte Gasparina che “disturba” realmente, gli altri – Cavaliere in testa – non sono da accettare completamente per una ragione meno logica. Non c’è pericolo reale (potrebbe esserlo il corteggiamento discreto del Cavaliere verso le ragazze?) ma pericolo virtuale. E c’è la differenza di classe, e linguistica, quasi di costume. È chiaro che il clan agisce qui in fase “conservativa”. Non ama scambi eterogenei tra i gruppi, ma scambi all’interno del gruppo, secondo leggi e rituali ben precisi. Il clan agisce in inconscia autodifesa contro tutto quello che è nuovo o diverso: non assimila, o per lo meno non vuole mostrarlo. Il fatto è che il campiello-clan è un organismo organizzato e autosufficiente anche se estremamente precario e straordinario.
È necessario a questo punto procedere nell’analisi del clan e indagare perché è precario e straordinario. Innanzi tutto le famiglie. Queste famiglie sono monche: a tutte manca la figura paterna. Delle tre famiglie presenti esistono solo madri, due figlie e un figlio. E i padri? Perché sono assenti? Perché sono tutti morti? Perché di loro si parla come di cosa remota, anche se un poco rimpianta e criticata? È questa una delle caratteristiche più straordinarie e meno spiegabili del Campiello.
…E qui appare la seconda divisione del campiello, dando per scontato il grosso enigma del matriarcato: il campiello ha due tipi di abitanti: vecchi e giovani. E per i giovani il campiello si erge repressivo, su una base ritualistica pronunciatissima.
È un clan con regole molto severe. Le giovani non possono stare in strada, devono stare su, alla finestra. La strada è la libertà, la permissività. Così, i due piani plastici della “scena-campiello” sono chiaramente definiti nello spazio: la piazzetta appare come il luogo “posseduto” dalle madri e dagli uomini, anche se giovani: luogo di incontri, di scontri e di giochi, vita socializzata, occasione di colloquio anche intimo. La casa in sé appare come il possesso personalizzato e privato delle singole famiglie. La finestra, e il balcone o l’altana, il luogo naturale di evasione relativa delle figlie, delle giovani. Nell’insieme il clan, composto di tanti piccoli clan, è il signore della piazzetta e non ammette eccessive intrusioni di “estranei”. Talvolta li accetta, come incidenti di breve durata. Questa società bene organizzata, anche se su temi quasi tribali, su una ritualità poco elastica, ha un suo ritmo, e le sue leggi, i suoi “costumi”, la sua “moralità”. Per questo le giovani femmine hanno la proibizione di uscire di casa da sole: possono solo stare “su” alle finestre, parlare tra loro, parlare anche al campiello, ai maschi che stanno “giù”, ma non hanno il diritto di scendere, di uscire, di socializzare nel campiello, se non accompagnate dalle madri o dai parenti stretti (lo zio).
Tutt’al più è concesso che una giovane esca di casa per correre “su” nella casa di un’altra, dove c’è la madre. Ma anche questo con timore e raramente. Esempio limite è il dialogo tra Lucietta e Gnese, la quale ad un certo punto regala un fiore all’altra. Le due case sono lontane, c’è di mezzo la piazzetta, e le due ragazze non sanno come fare per scambiarsi il fiore. Soprattutto la più giovane – Gnese – non può risolversi a portarlo all’amica-nemica. Lucietta, forse un poco più anziana, potrebbe tentare di scendere per salire a prenderlo, ma preferisce ricorrere ad un maschio – Zorzetto – che può agire liberamente nella piazzetta. Si propone a Gnese di gettarlo. Gnese rifiuta, perché quel fiore le costa lavoro e fatica: è un oggetto prezioso, non si getta e non si sporca. Il giovane propone di salire lui su da lei. Ma anche questo è impossibile poiché se alle giovani non è concesso scendere in piazza, ai giovani non è concesso salire nelle case dove ci sono le ragazze. Perché questo avvenga ci deve esser il permesso della madre e la sua presenza. Allora ci si risolve a farlo scendere, questo fiore quasi simbolo, in un cestino con la corda, affinché il giovane lo prenda e lo porti a Lucietta. Per darlo a Lucietta il giovane dovrà indubbiamente salire da lei, ma in casa c’è la madre. Gnese invece era sola poiché sua madre era salita da un’altra madre nella casa contigua.
Questa esemplificazione della complicazione e della presenza dei tabù sociali del campiello, è tipica e costituisce uno dei motivi fondamentali della commedia. Si tratta di cose “importanti” che a noi, pubblico contemporaneo, non sembrano tali. Ma nel contesto storico lo sono e non debbono essere sottovalutate: una grande baruffa nasce perché una ragazza è discesa o è salita o un giovane ha parlato troppo a lungo o è andato in casa di una ragazza, magari per vendere qualcosa. È che l’ordine raggiunto dal clan deve essere osservato, e ogni sua rottura rappresenta un pericolo per la sopravvivenza dello stesso…
19 febbraio
Il Cavaliere napoletano a Venezia, nel campiello che egli indaga, ama e vuole fare un poco suo, incontra una ragazza – Gasparina – che parla in modo strano, “caricato”, dice Goldoni: la zeta al posto della esse. Ma, a parte questo, è una ragazza che non vuole accettare il campiello come entità sociale, come stato di fatto. Lo contesta da destra, stupidamente si potrebbe dire, con il sogno fisso dell’altra classe, dei signori, dei nobili. Tenta a modo suo un distacco dal campiello al quale appartiene, cioè dal mondo plebeo. L’incontro tra i due – uno l’esterno che vuole inserirsi, l’altra che vuole staccarsi dal clan al quale appartiene; lui napoletano che non intende la lingua veneta, con strana pronunzia affettata, lei che non intende il toscano (o il napoletano a cadenza del Cavaliere) – è un incontro-scontro che non può non risolversi in qualche rapporto più preciso, amore a parte. Alla fine il Cavaliere – che concluso il carnevale “deve” andar via – non può che andar via con Gasparina, che vuole da “sempre” andar via. Ma non prima di avere scoperto che anche Gasparina è mezza nobile, figlia di un nobile e di una straccivendola, proprio come il nobile è figlio di un nobile e di una popolana: “Sono così ancor io!”, dice. La coppia si costituisce su molti interrogativi: quale sarà la vita di questi due? Comunque è certo che il Cavaliere dovrà cedere un poco della sua simpatia popolare, e Gasparina della sua incapacità di accettare “il popolo”: “zte zporche”. E difatti Goldoni lo fa capire con un tocco evidentissimo: con l’improvviso intenerimento del personaggio antipatico alla fine del quinto atto: nel congedo, nell’addio a Venezia, al campiello. Nell’attimo di lasciarlo Gasparina “sente” che è un momento serio, e scopre quasi con poche parole la “dolcezza” di quel mondo che rifiutava: ora che lo vede – si può dire – già un po’ a distanza, ora che la sua mania di nobiltà (psicanalisi compresa, complessi di inferiorità e di solitudine compresi) è un poco sazia, ora che è quasi fuori, altrove: “Venezia cara, Venezia mia”, addio a tutti, addio al campiello, cose e persone, lasciando giustamente sospeso un giudizio che positivo sarebbe stato veramente troppo subitaneo e convenzionale: “No dirò che ti zii brutto né bello…”. Altra invenzione: Gasparina non ha né padre né madre. Vive con uno zio. Questo zio è napoletano. Anche lui è uno straniero, venuto da poco, un Cavaliere, venuto da pochissimo, una giovane nata nel campiello ma già diversa, mezza nobile e mezza no, mezza veneziana e mezza napoletana per parte di padre. Il Cavaliere un poco scioperato, per amore di curiosità, non certo per “vizio”; di vizio non c’è traccia nel Campiello, e Dio sa se Goldoni era capace di esporre i “vizi” quando gli occorrevano! Non c’è perché Goldoni non lo voleva, voleva che le motivazioni del Cavaliere fossero più vaghe e profonde: non smania per il gioco, ad esempio. Però… “Non mi parlate di malinconia!”, dice con fraseggiare tipicamente napoletano il Cavaliere a Fabrizio, l’altro napoletano.
4 marzo
Per due volte, a distanza di anni, Goldoni mette in scena uno degli altri a contatto con il popolo, direttamente. Qui il Cavaliere, nelle Baruffe il Cogitore, lui stesso vent’anni e più prima, quindi con un’intensità e densità biografica misteriosa che carica di infinite risonanze il personaggio. Quanto nelle Baruffe ci sia di “diario”, di essere umano e privato, di classe, pochi l’hanno sottolineato; e quanto struggente e originale sia tale idea, molti lo ignorano. Resta comunque questo straordinario “documento” per vagliare la posizione umana, sociale, artistica di Goldoni alla vigilia della sua partenza per Parigi. E a mio avviso non se ne può prescindere. È certo un fallimento, o più che un fallimento gridato, una tacita rinuncia in punta di piedi: “sti siori dalla perucca co nualtri pescaori no i ghe sta ben…” e così via. Anche qui un tentativo d’inserimento, più attraverso il corteggiamento che attraverso “la carica”. Ma l’uno e l’altra visto come tentativo di “essere con”, anche qui l’impossibilità di accettarsi fino in fondo. Le classi restano divise, il gioco si chiude tra la gente della stessa “razza”. Nel Campiello lo stesso tema è sfiorato con chiarezza, anche se con minore o diversa profondità, dal Cavaliere napoletano. Che non è Goldoni giovane, che non porta memorie, che non ha alcuna carica per essere lì bensì attitudine umanamente democratica, curiosa ed amorosa verso la vita del campiello e dei suoi abitanti, per vivervi dichiarando: “Nol cambierei con un palazzo augusto: – ci ho con gente simil tutto il mio gusto”. Il campiello è una specie di rifugio nel tempo del carnevale, per questo “nobile” fuggito dalla patria, che ha viaggiato per tre anni ad occhi aperti, più che scialacquando non facendo conto del denaro. E vuole intorno allegria e visi sereni. Per lui, “Non parlatemi di malinconia, domani si vedrà, è carnevale”. Vuole farli come può lui, questi visi sorridenti: con discrezione ma entrarvi. Il mondo plebeo non lo assimila; e come potrebbe, se non in una commedia a tesi, finta, fuori della storia? Ma non lo scaccia nemmeno; lo accetta quasi; lo sta già accettando come presenza, e perde, a poco a poco, i toni di un rispetto ritualistico. Non è dei loro, alloggia in una locanda, ma può stare con loro: un poco burlato, un poco anche sfruttato (una cena finalmente vera ed abbondante), ed infine inserito come “compare” con diritti e doveri nel matrimonio che si celebrerà. Questa è stata la conquista umana del Cavaliere, a poco a poco, attraverso il suo muoversi nel campiello, il suo non capire, il suo sorridere, il suo corteggiare le ragazze perché è giusto che sia così, ma senza superbia, non al di sopra, ma alla pari. Diventa un personaggio a suo modo amato anche se sempre tenuto a distanza e talvolta oggetto di scherzo. Scherzo che il cavaliere accoglie sorridendo e talvolta sorridendo in rima: “Amico, di star con voi non me ne importa un fico”. Questo Cavaliere senza parrucca, che tiene in tasca come un berretto, questo Cavaliere che va nel campiello, in terra straniera, e si diverte di coloro che intorno esistono in quanto “casi umani”, gente che parla, ride, ama, grida e canta perché vera, è una straordinaria figura irripetibile per Goldoni, e che non ha riscontro nel suo teatro. Ma ecco un altro tocco incredibile: questo strano Cavaliere democratico è anche lui di padre nobile e di madre plebea. “Anch’io – dice – sono così”. E poi l’ultimo: è napoletano. Mi sembra che questo problema non sia stato assolutamente toccato né dalla critica né dalle precedenti edizioni teatrali; o io almeno non ne sono a conoscenza. L’estraneità etnica e linguistica del Cavaliere è fondamentale per lo svolgimento del lavoro. Il Cavaliere scopre Venezia per la prima volta: “siete mai stato in Venezia prima?” “No – risponde lui – è la prima volta”. Però d’altra parte – ed ecco l’originalità personale – è anche straniero: non è un ragazzo estatico, e soprattutto non è costretto ad essere lì perché coadiutore del cancelliere criminale, quindi con incarico ufficiale, ed egemone. È lì per libera scelta, perché gli piace quel paese, quel popolo, quella piazzetta, e perché in quell’ultimo carnevale preferisce far fuori gli ultimi soldini in quel luogo: “Oh, son pure obbligato – a chi un sì bell’alloggio m’ha trovato”. E s’inserisce nelle baruffe, negli amori; liti e gelosie degli abitanti del campiello, per “divertimento”, perché così gli piace, perché – dice – lì sta bene. E, si presuppone, lì più che altrove. Tutto questo non appartiene alle Baruffe; questo è autonomo. Cosicché i due personaggi, le due situazioni sono legate allo stesso tema fondamentale: “rapporti possibili-impossibili tra comunità popolare e gli altri”, ma con diverse sfumature, accenti, posizioni e caratteri. Il Cavaliere non ha in questo senso nulla a che fare con il Cogitore; non è una ripetizione, ma una autonoma invenzione su un unico tema di fondo. Non è difficile pensare che proprio questo tema appaia a Goldoni con questo accento nel 1756, e lo accompagni fino alla fine. Prima aveva suoni diversi, ma è riscontrabile ad esempio anche nella Putta onorata. Solo che lì non è un inserimento, ma la contrapposizione dura o il tentativo di “violenza” di un membro della classe egemone sulla “giovine” della classe egemonizzata.
8 marzo
Fabrizio, lo zio napoletano trasferitosi da poco a Venezia, appare come un intellettuale: studia sempre, legge sempre, ed impazzisce per il rumore e le grida dei campiellanti. Il popolo del campiello lo disturba: probabilmente non li capisce bene, i loro suoni gli sono estranei. Sapremo poi, con un colpo di scena eccezionalmente ironico, che questo “intellettuale” ricco che rimprovera il cavaliere napoletano povero e nobile per aver buttato via il danaro dalla finestra, che anche lui era ricco una volta, e poi si è rovinato, e poi di colpo si è ricostruito la fortuna: con una vincita straordinaria al gioco del lotto. Talché l’intellettuale estraneo appare improvvisamente anche lui come un improvvido e forse inveterato giocatore del lotto; forse i suoi libri intellettuali sono libri che trattono questo argomento, ed egli studia (e non fa altro) una maniera per vincere ancora. Fabrizio non fa altro che leggere ed arrabbiarsi, e il Cavaliere lo scopre nella sua realtà, che Fabrizio accetta naturalmente.
La ragazza, figlia a metà di nobili e plebei, è indubbiamente popolana e veneta, ma non del tutto: alla sua classe vuole sfuggire, ed anche al suo linguaggio: denota curiosità vivace ma superficiale alle cose, all’arte, alla classe egemone; nel suo negativo ha alcuni accenti positivi. Direi che non è rassegnata: è inquieta, anche se per motivi sbagliati, vuole essere di più, vuole sapere di più. Il positivo-negativo di Gasparina è uno dei caratteri più complessi di Goldoni: il popolare rinnegato; e si apre in lei una problematica sui caratteri profondi, su padri e madri, sull’ambiente familiare, sulla condizione femminile. La superficiale Gasparina, semi-napoletana e semi-popolana che non vuole esserlo, è un carattere non solo “ridicolo” ma in certi punti quasi straziante, certamente toccante, e il suo “vizio” è pieno di ombre, di ritrosie e di coraggi, di incertezze e stupidità, ma anche di slanci trattenuti, sogni legittimi, capacità di oltrepassarsi.
Il Cavaliere è di passaggio, come un turista curioso e innamorato. Sta lì negli ultimi giorni di un carnevale che non arriva mai al campiello, talché egli lo ricrea da sé con inviti a pranzo, orchestrina e vino, poiché il carnevale non oltrepasserebbe mai queste povere mura, dove c’è poco sole e tanta neve, e povertà estrema e tanta indigenza. Ma tutto ciò che vede e tocca, egli lo trova giusto, positivo, interessante e amorevole. Non è la curiosità del ricco per la povertà: è moto semplice dell’animo, un poco “labile” ma generoso, nel quale forse il “mezzo plebeo” della sua nascita gioca un ruolo quasi inconscio.
14 marzo
Nel Campiello non è mostrata la “permissività” della classe egemone, che sola potrebbe far riscontro alla severità della classe egemonizzata. Ma noi sentiamo che la regola del mondo dei poveri ha sì da una parte una certa misura e ristrettezza, ma anche una sua chiarezza, una serie di principi di comportamento che lo presentano come un mondo ancora compatto, non disgregato, solidale e regolato e autoregolato con antica saggezza.
1° maggio
Rileggo queste prime note incomplete e mi viene da pensare come chiaramente i grandi poeti di teatro con i loro grandi testi si facciano scegliere da sé, attraverso una misteriosa costrizione di cui noi interpreti diamo giustificazioni “logiche” perché non vogliamo accettare quasi l’idea di essere scelti.
Vogliamo orgogliosamente essere noi “interpreti” a decidere. Ma la realtà che Jouvet ha descritto così bene in certe sue pagine lancinanti è questa: ad un certo punto nel materiale talvolta enorme di “cose di teatro” che il teatrante porta con sé nel tempo – testi, personaggi, idee, persino solo titoli o suoni –, qualcosa si propone con violenza dolce. (Il viaggio-apparizione dei sei personaggi a Pirandello, è un esempio raccontato!). E allora nonostante talvolta resistenze conscie ed inconscie il vero interprete, sempre pronto a cedere a questa violenza perché tale è la sua condizione di umano strumento, finisce per acconsentire: senza sapere bene il perché. Così fu per la scelta del Lear, un qualche cosa che da sempre io avevo rifiutato, contro il quale avevo combattuto anche per paura, per un enorme rispetto per questa poesia così difficile, troppo difficile. Così per Il campiello di Goldoni.
La verità oggi, alla fine quasi delle prove, è che questo testo è straordinario, è irripetibile e ricchissimo, è tenero in un amore per il popolo povero e senza carnevali in un giorno di carnevale, è pieno di rapporti nuovi tra i personaggi, è pieno di una grandissima umanità e stilisticamente è un esempio irripetuto – mi pare – di scrittura. Cioè è un’opera d’arte che io ero pronto – maturo? – a fare. È un qualcosa che doveva essere comunicato al pubblico in colloquio amorevole.
Tutto il resto sono apposizioni o giustificazioni quasi inutili. Si fa Il campiello perché ne abbiamo tutti bisogno anche se non parla dei nostri problemi quotidiani o della nostra lotta per costruire un mondo migliore o altro. Ne abbiamo bisogno nella sua misura di tenerezza su un mondo minore, sulla sua realtà di vita in un certo momento della storia ieri come oggi, perché senza questa tenerezza viva, ogni azione “politica” giocata su un versante popolare, non è niente. Anche una rivoluzione senza amore è solo violenza e nasconde gli agguati dell’orrore.